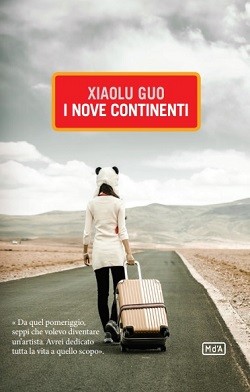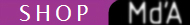La scelta di privilegiare scrittori rimasti in patria
Nella presentazione dell’ospite d’onore sul sito del Lingotto ( http://www.salonelibro.it/it/salone/paese-ospite.html) , c’è una frase che mi è molto piaciuta: “Il Salone 2010 vuole privilegiare i narratori che sono rimasti in patria, a vivere e descrivere una realtà che con la sua debordante umanità resta un gigantesco serbatoio di storie capaci di coinvolgere il lettore.” E’ una scelta perfettamente in linea con la visione fondante di Metropoli d’Asia: cercare scrittori che in quelle città vivono, che ne battono le strade e i quartieri, che sono direttamente coinvolti e messi alla prova dal cambiamento in certi casi devastante delle loro città. Non solo in India, ma in tutta l’Asia, le grandi metropoli sono il centro e il motore di uno sviluppo economico e di una modificazione delle condizioni di vita che ne rende gli abitanti molto più simili a noi di quanto non accadesse un paio di decenni orsono. Ecco dunque imporsi una nuova generazione di narratori che trattano temi a noi vicini, superando quello stereotipo datato che vede nell’asiatico un altro da noi, distante, ancorato al premoderno, a una condizione di vita rurale, in qualche modo magica e sognante, di cui è utile raccontare il passato più che il presente perché questo ci porterebbe a toccare corde a noi inusuali, sopite e travolte dalla modernità e dallo sviluppo. E’ una visione che gli indiani, in particolare, hanno contestato e ancora contestano come orientalistic, e cioè esoticizzante (uno dei termini utilizzati, forse un po’ troppo enfatico è: neocolonialista). Gli scrittori contemporanei indiani ci chiedono invece di prendere atto dei mutamenti: e ci propongono delle storie che per noi sono sorprendenti e attraenti proprio perché ci cinvolgono in modo diretto, toccando temi che sono anche i nostri. E’ il caso, credo, de La Tigre Bianca di Aravind Adiga, che raccontando la vicenda di un servo e dei suoi padroni nell’india di oggi ci ricorda probabilmente i servi di casa nostra. O del Le Ceneri di Bombay di Cyrus Mistry, pubblicato da MdA qualche mese fa, nel quale il protagonista – scrittore a sua volta – si interroga sulla propria capacità o meno di narrare una Bombay dove fomentando le tensioni interetniche e interreligiose per costruire le proprie fortune politiche, gruppi di potere costruiscono furiose speculazioni edilizie e fortune industriali (e non è casa nostra questa?). O del nostro Il Mio Ragazzo di R Raj Rao, che ambienta le problematiche della discriminazione omosessuale nell’India delle caste e delle discriminazioni sociali.
Ecco, io penso che solo scrittori pienamente residenti siano in grado di interpretare queste nuove realtà e di raccontarcele trovando modo di tenerci legati alla loro narrazione. Per questo abbiamo scelto di non pubblicare autori della diaspora, residenti o perfino nati in Europa o negli Stati Uniti: non certo perché pensiamo che la distanza impedisca di costruire buona scrittura e buone narrazioni, ma perché siamo convinti che sentire sulla propria pelle i mutamenti abbia un effetto anche nel costruire la personalità artistica di un autore, e siamo curiosi di scoprirne il risultato. Nessun NRI – Non Resident Indian – dunque. Ma ci siamo spinti più in là, tendendo a scartare anche gli autori più giovani che abbiamo scoperto essere emigrati verso le più prestigiose High School anglosassoni quando ancora erano teen-ager, tornando nel loro paese solo per le vacanze: sulla base di quale esperienza, dopo ventanni lontani, ci possono raccontare la New Delhi, la Bombay, la Bangalore contemporanea? Abbiamo invece amato autori che vanno fieri della propria nazionalità al punto da sobbarcarsi l’inevitabile fatica dell’esistenza nei quartieri più affollati di Bombay pur di sentirsi in grado di raccontare la loro città. E ancora di più coloro sui quali la globalizzazione produce l’effetto opposto: la voglia di ritornare, la curiosità di vedere cosa succede nella nuova India.
E che il risultato di questa scelta sia, in tempi di comunicazione virtuale e delocalizzazione, il suo esatto contrario, e cioè riscoprire il legame con il luogo e il genius loci che di volta in volta a quello presiede, beh non mi dispiace per nulla.