 Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di Salman Rushdie al Jaipur Literary Festival. Siamo in periodo pre-elettorale e tutto fa gioco: voti musulmani da conquistare. Ricordiamoci che siamo in un paese dove i fondamentamentalismi religiosi (quello indu su tutti) sono vastamente utilizzati come strumenti di consenso elettorale e di potere.
Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di Salman Rushdie al Jaipur Literary Festival. Siamo in periodo pre-elettorale e tutto fa gioco: voti musulmani da conquistare. Ricordiamoci che siamo in un paese dove i fondamentamentalismi religiosi (quello indu su tutti) sono vastamente utilizzati come strumenti di consenso elettorale e di potere.
Tutti sono abituati al succedersi di casi del genere. A tratti, con una certa regolarità purtroppo, la conflittualità interreligiosa (che si sovrappone a quella tra Pakistan e India) esplode, nel senso letterale del termine: pogrom, attentati, bombe. Saltano per aria stazioni ferroviarie e altri luoghi frequentati. E questi sì sono fatti importanti.
Ma la notizia delle manifestazioni anti-Rushdie viene trattata dagli organizzatori del Festival e dagli scrittori e intellettuali locali come fatto di routine. Appunto, siamo in un paese che alle notizie minori ci ha fatto il callo.
Il giorno dopo Rushdie annuncia di avere ricevuto dai servizi segreti la notizia che da Bombay sono in partenza due (o tre) killer prezzolati per ucciderlo: e rinuncia al festival. La notizia, di nuovo, è accolta con una certa sufficienza a Jaipur: gli organizzatori chiedono esplicitamente alla stampa di occuparsi degli altri scrittori e non solo del caso Rushdie. La sensazione prevalente è: Rushdie (odiatino e invidiato, uomo di grande potere) si sta facendo un po’ di pubblicità, i politicanti ci rompono come sempre le scatole, il fondamentalismo è la solita tara, ma noi cerchiamo di tirare dritto.
Quattro scrittori invece iniziano una protesta: in apertura delle loro sessioni di dibattito iniziano a leggere brani da I versi satanici. Gli organizzatori accorrono e chiedono loro di sospenderne la lettura. Improvvisamente tutti si rendono conto che il libro è censurato in India (paese a maggioranza induista, non c’è nessuna Sharia, qui). Anzi le autorità locali, saputo dell’accaduto, consigliano ai quattro scrittori di lasciare immediatamente il paese, perché esiste il rischio concreto di essere arrestati (per loro, e il rischio che nel frattempo si spostino consistenti pacchetti di voti).
Di nuovo, la cosa viene accolta come si accoglie la grandine: è l’India, ne succedono di cotte e di crude ma andiamo avanti. Parte una petizione contro la censura a I versi satanici, e qualcuno fa osservare che i libri censurati sono molti, in India: urge un censimento. E le censure appaiono avere carattere di assurdità spesso e volentieri, proprio perché risultato di manipolazioni del consenso da parte di piccoli e grandi potentati politici, a livello nazionale e locale.
Ma quando le autorità centrali (e i servizi) annunciano che non è mai partito nessun allarme riguardo ai killer, e che anzi l’allarme è da considerarsi risibile, a molti cadono le braccia. Rushdie è atteso da un giro di conferenze stampa: c’è un film in produzione tratto da I figli della mezzanotte.
In conclusione: al di là del consueto show mediatico e pre-elettorale, mi pare di vedere tre posizioni differenti.
La prima è quella di autori indiani in voga, vedi il Moccia locale Chetan Bhagat (stranamente tradotto in Italia da un editore bravo e attento come E/O), che rappresentando in modo organico (così si diceva una volta) la cultura del ceto medio indiano, afferma che se Rushdie ha offeso i sentimenti religiosi di qualcuno è giusto che sia perseguito. In sostanza: in India emerge una classe di moderni benpensanti e gli scrittori da show li rappresentano pienamente.
La seconda posizione è quella di autori indiani non residenti, cioè di cittadinanza (e magari nascita) americana o britannica, che reagiscono in modo automatico alla fatwa, senza farsi troppe domande sul contesto: come se il fatto accadesse a Londra.
La terza è quella di molti scrittori e intellettuali indiani (è abbastanza chiaro che io concordo con questi ultimi) che prendono spunto per aprire una campagna sulla censura, ma insistono nel ricordare che in questo paese i problemi sono ben altri (e soprattutto i killer: sui giornali veniva in questi giorni confinata in pagina interna la notizia di quattordici tra poliziotti e cittadini trucidati da un assalto maoista nel nord-est del paese, e sarebbe stato la stessa cosa se si fosse trattato del solito omicidio di massa di contadini da parte delle forze di sicurezza indiane). Salman Rushdie, per queste persone, è proprio l’ultimo dei problemi, in India.
Nota a margine: le prime due posizioni esprimono dei luoghi comuni. La terza è posizione da scrittori veri proprio perché lontana dal luogo comune (o stereotipo che dir si voglia).
Seconda nota a margine: noi occidentali dobbiamo stare molto attenti a non riproporre i nostri luoghi comuni nelle realtà altrui.
E comunque: no alla censura.
PS: In Italia esistono libri e/o spettacoli censurati? Quali? Che sentimenti religiosi offendono?
Foto: kittell


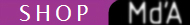


 Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di
Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di 

 Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare
Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare 


 Tornare a
Tornare a  Avevo trovato il suo The Boyfriend (
Avevo trovato il suo The Boyfriend (


