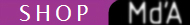Vien da pensare al I would prefer not to di Bartleby, se non altro c’è un assonanza. È invece inquietante, vagamente minacciosa questa frase, I strongly suggest you do not , soprattutto se pronunciata a pochi giorni di distanza – poche ore in verità –da due diverse persone a Shanghai e a Pechino.
Vien da pensare al I would prefer not to di Bartleby, se non altro c’è un assonanza. È invece inquietante, vagamente minacciosa questa frase, I strongly suggest you do not , soprattutto se pronunciata a pochi giorni di distanza – poche ore in verità –da due diverse persone a Shanghai e a Pechino.
La seconda, in particolare, insiste per vedermi al più presto, appena sbarcato nella capitale. Come se avesse paura che senza il suo avvertimento io possa spingermi troppo in là, superare un limite. Lo avevo preannunciato via mail: vorrei delle introduzioni, vorrei replicare in Cina quel che ho messo in movimento a Singapore, a Delhi, a Kuala Lumpur: entrare in società con editori locali. A Pechino e Shanghai avevo da tempo dei contatti, qualche discussione era iniziata e si era poi arenata.
Zheng Shi è editor del Beijing Publishing Group. Si occupa di narrativa, mi era stata presentata da amici all’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, cercava una casa editrice italiana disposta a garantire per lei, e farle così ottenere un visto per l’Italia e poi per altri paesi europei: uno stage da noi, insomma, mezzo finto mezzo vero.
Ci eravamo incontrati in precedenza a Pechino, ricordo una pantagruelica anatra laccata (più di una in verità) in un ristorante vecchio stampo: un enorme atrio neoclassico, ampi tavoli rotondi ricoperti di tovaglie rosse, drappeggi di velluto alle finestre: realismo socialista per dirigenti, in una città che appariva come sempre stilizzata, illuminata di una luce tenue invernale, palazzoni dal volto comunque gentile lungo viali a scorrimento rapido.
Le utopie del socialismo nelle capitali si riducono a questo: una serena e razionale facilità nel raggiungere i ristoranti d’elite. Pechino è orizzontale, i grattacieli raramente superano il quindicesimo piano, e il traffico è organizzato entro le sue highway concentriche (Primo Anello, Secondo Anello, Terzo Anello: molto Orwelliano, sì). (L’anatra laccata, per chi non lo sapesse, consiste in una successione di portate nelle quali il volatile in questione viene completamente disossato e reso commestibile in tutte le sue parti: dell’anatra non si butta via niente, come da noi il maiale).
Zheng Shi con me è sempre stata aperta e generosa, non solo per le cene in successione assieme a gente interessante, ma anche nell’approccio: ridanciana, chiacchierona, una miniera di informazioni. Certo, da me aveva bisogno del pezzo di carta in questione, ma le veniva facile tutto, capivo che si divertiva davvero.
Questa volta giunge compita al mio albergo, sceglie un tavolo lontano. Il suo I strongly suggest you do not è motivato, ma soprattutto condito da una tensione che non le avevo mai visto sul volto. La parola più utilizzata è: Loro. Loro fanno quello che vogliono, loro sono in grado di far fallire ogni iniziativa. Loro non cederanno alcuno spazio nel paese a gente venuta da fuori.
La frase, appunto, ripete esattamente quella di Lily Chen a Shanghai, due giorni prima. Le due grandi metropoli gemelle della Cina, l’una in mandarino, l’altra in cantonese. In inglese suona pari pari: I strongly suggest you do not.
Shanghai è diversa. qui c’è un fiume sinuoso a far da riferimento. Oltre quello, incastonata nell’ansa di Pudong, la città nuova dei grattacieli, il JinBao uscito da un fumetto di Flash Gordon mezzo missile mezzo teiera, e l’altissimo Financial Centre che le autorità rimuovono dalle fotografie: è di proprietà della Banca del Giappone, un insulto all’orgoglio nazionale: bellissimo, un manufatto che a me ricorda il monolite di 2001 Odissea nello Spazio.
A ovest del fiume la città si declina in quartieri dall’identità propria, come una New York delle molte nazionalità. Il centro cinese, la French Concession, la zona intorno a People Square, la città vecchia, il lungofiume monumentale: il Bund, che par di essere a Vienna. Era città franca, Shanghai, città del commercio internazionale. Ancora oggi la meno cinese tra le metropoli del Paese di Mezzo.
L’ufficio della Big Apple, agenzia letteraria tra Cina, Giappone e Isole Hawaii, sta in un palazzotto all’ombra di un gigantesco cavalcavia: dentro, ricordi di un tempo: un grande spazio bianco diviso in due da un tramezzo in legno traforato, bianco, piantine alle pareti e su ogni ripiano, scaffalature dense di volumi e grandi finestre, una luce discreta ma chiara, distinta. Al di qua del tramezzo gli editor, le piccole scrivanie tutte uguali, e un piccolo soppalco di legno nel mezzo, bianco, con un divano e una tavolino dove far sedere gli ospiti.
Oltre il tramezzo un arredamento più da appartamento che da ufficio, lampade da tavolo colorate e di design, le poltrone. E il bassotto, che Luc Kwanteen (origini europee, chissà quante storie Shanghaiesi alle spalle) tiene in braccio e accarezza mentre mi parla seduto su una bella poltrona: bianca. Dicono di Lily Chen: era bellissima da giovane. Dicono di lui: gran conquista, ma vita dura. Dimostra anche oggi una decina di anni in più della moglie, ma ambedue non so come situarli: settanta e sessanta? Di più, di meno?
I strongly suggest you do not. Amabile, whisky per lui vino rosso per me e Lily Chen, sciorina la lista dei fallimenti provocati o evitati per un pelo. Su tutti Bertelsmann, l’hanno lasciata partire, gli assegni staccati, la macchina già in moto e tutt’a un tratto gli si nega la distribuzione, non vendono più un libro, bancarotta. Poi Penguin che l’ha capita in tempo e dopo soli tre mesi di pubblicazioni ha trasformato l’ufficio di Pechino in sede di rappresentanza: compra e vende ai padroni del mercato.
Cercavo di capire se le motivazioni di questa rigidità commerciale fossero politiche: la censura, in paese che ne fa il baluardo della sua invincibilità. Mi dicevano di no: è industria di stato, quindi organizzata per cordate, potentati, a ciascuno la sua fetta e nessuno tocchi l’osso. Io spiegavo: ma non sono mica Penguin, io. Cerco rapporti con case editrici minori, indipendenti. Non c’è indipendenza editoriale, mi rispondeva Lily Chen, in Cina. E comunque stai attento, questo è un paese difficile. Non sai mai cosa sta per succederti: sai, è un paese comunista.
E quindi I strongly suggest you do not prima a Shanghai e poi a Pechino, pari pari, mi diventa minaccioso, cosa c’è dietro? Per presentarmi, per chiedere introduzioni, avevo spedito una mail al mio indirizzario cinese: anche al nome sbagliato? Qualcuno che poi ha mandato in giro messaggi trasversali, uomo avvisato?
Zheng Shi, dal canto suo: non posso dimenticarmi che alla fine, lei, non era mai arrivata a Milano: il tempo perso da noi per inquadrarla, fornirle un documento di lavoro temporaneo, non era stato ripagato. Mi aveva scritto da Londra e dall’Olanda, mi aveva detto che l’Ambasciata d’Italia non le aveva concesso il visto, ma qui c’è Shenghen, libera circolazione, di che parli? Insomma si era girata l’Europa per un po’, ma a Milano non era mai scesa.
Adesso, con quella frase che si rigira tra le mani mi sembra perfino diversa dalla persona che conoscevo: più magra, gli occhiali dalla montatura spessa, i capelli raccolti in una coda. Ha cambiato stile, per incontrarmi oggi? I strongly suggest you do not: che farò?
Foto: Thierry