 Una delle architetture piu belle della scintillante Singapore è la National Library, un raffinato esercizio di equilibri di vetro e acciaio bianco, sulla cima del quale spicca, tondeggiante, il POD, una struttura che ricorda lo Scrigno del Lingotto a Torino, appoggiato su un angolo dell’edificio, sporto sulla citta.
Una delle architetture piu belle della scintillante Singapore è la National Library, un raffinato esercizio di equilibri di vetro e acciaio bianco, sulla cima del quale spicca, tondeggiante, il POD, una struttura che ricorda lo Scrigno del Lingotto a Torino, appoggiato su un angolo dell’edificio, sporto sulla citta.
Ci si appoggia alla balaustra e ci si gode il passaggio dal giorno alla notte, in questa metropoli che sta diventando una delle piu belle del mondo.
Del resto, non si puo far altro che guardar fuori: la presentazione del nuovo romanzo di Yeng Pway Ngon è interessante, un’ora di discussione serrata, ma rigorosamente in cinese… Non sono l ‘unico sorpreso dalla scelta, ma il romanzo è scritto in cinese complesso (quello di Taiwan, per intenderci, che perfino i nostri traduttori piu esperti fan fatica ad affrontare), il mio amico Pway Ngon si sente piu a suo agio in cinese che in inglese, e…
E a questo punto anche a Singapore si comincia a sentire l’influenza del Dragone. Arriva la letteratura cinese in cinese, se ne prendono le televisioni, e la sua popolazione di origine cinese si chiede perché fare la fatica di comunicare sempre e cominque in inglese, visto che in casa si parla il dialetto Hokkien, Cina meridionale.
Mi avevano detto che la narrativa di lingua cinese e malese qui sta riducendosi al lumicino. In tutto il mondo dove l’inglese è disponible (penso all’India, a tanti paesi africani, alle Filippine della diaspora), prima o poi l’inglese vince. Ora invece, in Asia, comincia a regredire: l’altroieri ho postato su Fixi, la collana in malese di Amir Muhammad a Kuala Lumpur. E ora questo segnale chiaro.
In ogni caso daremo in lettura a un esperto di cinese complesso il romanzo di Pway Ngon: una storia che si nutre nella sua autobiografia, e segue un gruppo di personaggi dagli anni Sessanta ai Dieci, da una giovinezza ribelle di mobilitazioni per lindipendenza prima e per la democrazia poi, alla Singapore odierna, dove nasce un’opposizione parlamentare che prende il 40% dei voti e il Web detta legge. Singapore comincia a lievitare nella mediasfera: se ne e’ accorto anche Pascale, sul Post.
Foto: inju

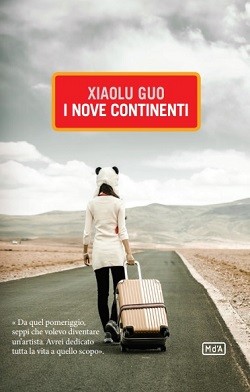
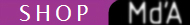


 Abbiamo già parlato di
Abbiamo già parlato di  L’ultimo weekend del
L’ultimo weekend del  Due weekend, e in mezzo un mercoledì festivo (
Due weekend, e in mezzo un mercoledì festivo ( Da un anno cerco di scrivere un post su
Da un anno cerco di scrivere un post su  Dedito, mi spiega lui, a “costruire modelli di aggiustamento dei default”. Gli ho chiesto: sarai mica uno di quelli che han combinato il megacrac? Dice no, semmai i miei modelli servirebbero a rientrare. Ma io sono solo un matematico, di soldi non ne so nulla. Dunque finanziario, matematico, poeta, di cognome fa Toh e Hsien Min di nome.
Dedito, mi spiega lui, a “costruire modelli di aggiustamento dei default”. Gli ho chiesto: sarai mica uno di quelli che han combinato il megacrac? Dice no, semmai i miei modelli servirebbero a rientrare. Ma io sono solo un matematico, di soldi non ne so nulla. Dunque finanziario, matematico, poeta, di cognome fa Toh e Hsien Min di nome. Da Cha: An Asian Literary Journal troviamo la
Da Cha: An Asian Literary Journal troviamo la 
 Nonostante il mercato cinese dell’editoria digitale attraversi ancora qualche difficoltà, dovute tra le altre cose alla mancanza di piattaforme di distribuzione uniformi, scarsezza di carte di credito e pericoli derivanti dalla pirateria, il caso di
Nonostante il mercato cinese dell’editoria digitale attraversi ancora qualche difficoltà, dovute tra le altre cose alla mancanza di piattaforme di distribuzione uniformi, scarsezza di carte di credito e pericoli derivanti dalla pirateria, il caso di 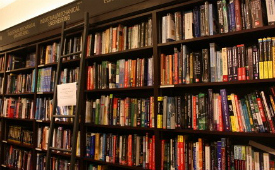 A una anno di distanza, una verifica dei cambiamenti in atto a
A una anno di distanza, una verifica dei cambiamenti in atto a 

