 Atterro a Bombay e scopro che il Nokia d’anteguerra dove archiviavo i numeri indiani mi ha lasciato. Ho le mie scatoline di biglietti da visita, certo, ma sento la mancanza dei numeri degli amici, le cui vecchie caselle di posta elettronica mi rimandano messaggi d’errore.
Atterro a Bombay e scopro che il Nokia d’anteguerra dove archiviavo i numeri indiani mi ha lasciato. Ho le mie scatoline di biglietti da visita, certo, ma sento la mancanza dei numeri degli amici, le cui vecchie caselle di posta elettronica mi rimandano messaggi d’errore.
Ci penso mentre vado a zonzo per le vie di Colaba, sul lungomare, percorrendo l’Apollo Bunder dal Gateway of India (un brutto arco con decorazioni dallo stile incerto che fungeva da segnale di saluto per i navigli in arrivo dalle isole di Sua Maestà Britannica) al Radio Club, passando davanti all’ingresso del Taj Mahal Hotel (che è strano davvero: qualcuno ha detto che l’architetto ha fatto costruire questo magnificente albergo girandolo per il verso sbagliato: qui sembra di entrare dal retro, è vero che i cavalli in pietra segnalano l’ingresso, che però si compone di due porte piccole, basse; dentro, si apre un ambiente che va su fino alla grande cupola, con uno scalone che lo risale: sembra un ingresso tardi anni Ottanta, postmoderno!).
Dietro l’Apollo Bunder c’è un quartiere di strade ortogonali e edifici che nella fatiscenza tipica di Bombay conservano tracce di splendore: porticati, parti in legno, scalinate esterne, finestroni ampi e contornati di colonnine, la scelta stilistica è pure qui incerta, ma i giardini sono lussureggianti di piante tropicali, le vie interne riposano in un silenzio inatteso per questa caotica città. In una di queste vie abita Meher Pestonji, scrittrice di etnia Parsi che mi ha sempre offerto buoni bicchieri di liquore e utili e piacevoli chiacchiere.
Ma non riesco a ritrovarla, la casa. Non ricordo il nome della via, né la posizione esatta, né soprattutto riconosco un edificio. Oliver street? Forse. La casa era in un fiorente stato di abbandono, riconosco un possibile vialetto di ingresso ma a un edificio ristrutturato di recente e dipinto di un rosso granata (presente la maglia del Torino?) un po’ fuori luogo (benchè… ricorda l’Old Fort di Delhi, in fondo il colore è indiano). Chiedo all’immancabile guardiano: Pestonji? Sì, mi fa. Ma è appena uscita, c’è su la figlia.
Bene, allora ci sono. Ma: la figlia? Ricordo una giovane donna che si porta dietro un evidente stato di difficoltà. Ricordo la fatica di Meher nel descrivermela. Ricordo gli amici comuni dirmi: eh certo, poi lei ha Nishat. Nishat che si aggira per casa in pigiama, che ha deciso di posizionare la propria stanza da letto proprio all’ingresso di casa, per farsi ben guardare dagli ospiti mentre se ne resta rannicchiata sulla branda traballante che pretende di usare come letto. Nishat comunque discreta, gentile, che saluta distante come una persona in preda a una profonda depressione (o forse semplicemente sotto farmaci).
Salgo, lascerò un biglietto da visita con il mio numero.
Meher, dal canto suo, è una Parsi anomala: ha rotto la tradizione sposando un non Parsi, fatto che come è noto provoca alti lai tra i famigliari e rimostranze a non finire. Nel suo caso una rottura totale (anche se, va detto, è ormai pratica corrente tra le nuove generazione e i Parsi si stanno estinguendo: o almeno, così dicono loro, perché parsi si può definire solo il figlio di due Parsi! Strana attitudine, comune tra le minoranze, quasi un desiderio di suicidio etnico).
Meher ha reagito alla rottura diventando scrittrice. Il suo primo libro di racconti porta il titolo di Mixed Marriage, e ovviamente affronta l’argomento di petto. Dopo il divorzio con il marito (etnia: Cristiano), diventa giornalista e comincia a scandagliare le baraccopoli di Bombay. Ne risultano due romanzi, Sadak Chhaap e Parvez centrati rispettivamente su un bambino di strada e su una attivista.
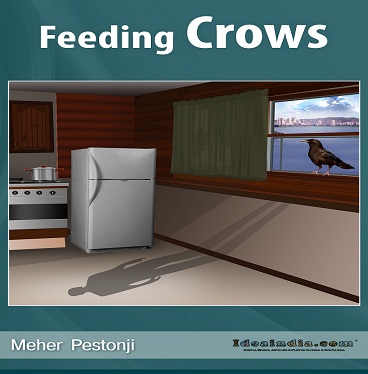 (Di Meher ho già citato il suo testo per teatro: Feeding Crows, naturalmente organizzato attorno alla tradizione dai funerali Parsi. I corpi vengono lasciati sulla terrazza delle Torri del Silenzio, a Bombay, perché siano divorati dalle aquile pescatrici, o dagli avvoltoi. Problemino: le aquile pescatrici non ci son più, a Bombay, e cominciano a scarseggiare gli avvoltoi…. Un testo la cui evidente ironia aveva provocato crasse risate da parte di un uditorio, così mi disse Meher, in maggioranza Parsi).
(Di Meher ho già citato il suo testo per teatro: Feeding Crows, naturalmente organizzato attorno alla tradizione dai funerali Parsi. I corpi vengono lasciati sulla terrazza delle Torri del Silenzio, a Bombay, perché siano divorati dalle aquile pescatrici, o dagli avvoltoi. Problemino: le aquile pescatrici non ci son più, a Bombay, e cominciano a scarseggiare gli avvoltoi…. Un testo la cui evidente ironia aveva provocato crasse risate da parte di un uditorio, così mi disse Meher, in maggioranza Parsi).
Il solito inquietante ascensore sferraglia su fino al quarto piano. L’interno dell’edificio non è certo ristrutturato come la sua facciata, la scala è piena di calcinacci e, direi, materiali vari che danno l’idea di essere abbandonati lì da mesi. Come spesso in queste case la porta in legno è aperta, ma resta chiuso un cancelletto. A destra e a sinistra del corridoio le porte delle due stanze gemelle che Meher affitta: in alto sopra lo stipite la statuetta di Anuman, dio scimmia, da un lato, e il più comune Ganesh dall’altro.
Viene a aprirmi Nishat: che sommessamente mi riconosce, dopo quasi tre anni. Ma appare subito padrona di sé, con semplicità mi invita a sedermi in un salotto che ricordavo come squallido, illuminato da due tubi fluorescenti di gelido neon.
Nishat mi offre un tè. Mi propone i suoi biscotti appena usciti dal forno. Il salotto ora è pieno di oggetti d’arte, soprattutto statue in ferro a metà tra la tradizione e l’arte moderna, dovrò chiedere a Meher di cosa si tratta. E due belle lampade liberty fanno buona mostra di sè, e calore. (Il salotto peraltro è affacciato su due terrazze strepitose: un angolo di mare, i giardini di Colaba).
Certo, è sempre Nishat, il suo sguardo ha un che di opaco, come se ne restasse nascosta dietro a una distanza che le consente di non esibire emozioni, negative o positive che siano, e di non esserne sopraffatta. Come se non reagisse emotivamente.
Ma viene a sedersi con me, mi domanda di Metropoli d’Asia, e mi racconta del suo libro: sì ha pubblicato un libro. Sono ricette di cucina, l’editore è Poular Prakashan: editore locale, ma noto e ben distribuito. Il libro è stato presentato da Crossword, la libreria più importante della città, da una specie di star televisiva, che tiene una trasmissione di cucina molto seguita.
Dietro alla sua compostezza intuisco Nishat raggiante. Le ricette sono una personale reinterpretazione delle molte cucine presenti in India, contaminate tra loro: una sorta di nouvelle cuisine indiana, una fusion: in copertina una papaya farcita di ceci e altri legumi. Mi invita a cena, per una prossima serata.
Dalle nostre parti spesso riemerge una annosa questione (un “dibbattito”): chi scrive non vive, chi vive non scrive. Le Pestonji, madre e figlia, scrivono PER vivere. Meglio.
 Apprendiamo da Paper Republic di una nuova rivista letteraria che circola in Cina. Si chiama Pathlight – New Chinese Writing e attualmente si trova in procinto di pubblicare il secondo di tre numeri di prova.
Apprendiamo da Paper Republic di una nuova rivista letteraria che circola in Cina. Si chiama Pathlight – New Chinese Writing e attualmente si trova in procinto di pubblicare il secondo di tre numeri di prova.
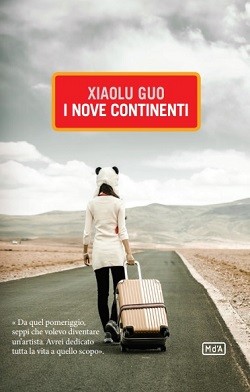
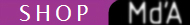



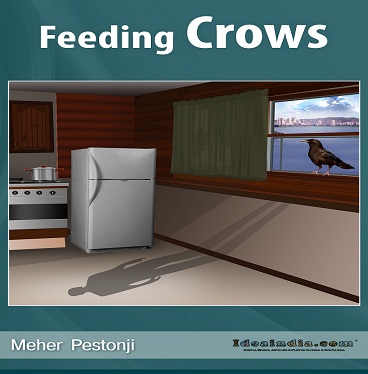

 Qualche tempo fa Associna
Qualche tempo fa Associna  Tornare a
Tornare a 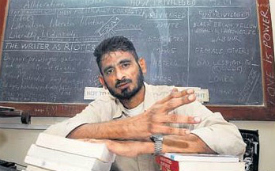 Avevo trovato il suo The Boyfriend (
Avevo trovato il suo The Boyfriend (
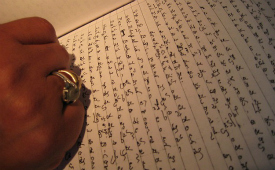 Nella prossima edizione del
Nella prossima edizione del  La
La 

